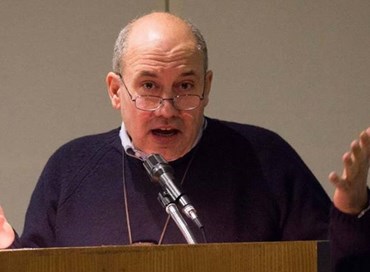 Nella Asl Roma 5 di Tivoli si è tenuto il primo tavolo italiano di discussione sulle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), con la significativa partecipazione di una rappresentanza delle persone assistite nelle strutture, oltre che dei sindaci in rappresentanza della cittadinanza ospitante le strutture, degli operatori sanitari e aziendali, del Garante dei detenuti.
Nella Asl Roma 5 di Tivoli si è tenuto il primo tavolo italiano di discussione sulle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), con la significativa partecipazione di una rappresentanza delle persone assistite nelle strutture, oltre che dei sindaci in rappresentanza della cittadinanza ospitante le strutture, degli operatori sanitari e aziendali, del Garante dei detenuti.
Per la prima volta ci si è seduti tutti insieme allo stesso tavolo per valutare le attività in corso e per discutere dei problemi da affrontare. Purtroppo a questo tavolo, per una problematica improvvisa, mancava la Procura che ha un ruolo importante in questa vicenda; non bisogna dimenticare inoltre che sebbene la riunione fosse in una Asl specifica, quella di Tivoli, nelle Rems ci vanno persone provenienti da ogni parte della regione. È importante la partecipazione degli organismi giudiziari, anche quelli che istruiscono i procedimenti, perché uno dei problemi più gravi è di lavorare sempre nella più stretta necessità. Abbiamo chiesto al Garante dei detenuti, Stefano Anastasìa (nella foto), presente alla riunione, una sua opinione sulla situazione obiettivamente anomala che vivono buona parte delle persone ospitate nelle Rems, molte delle quali ancora in attesa di una decisione definitiva da parte della magistratura sulle loro condizioni di salute mentale, sulla loro pericolosità sociale, come se fossero, diciamo, in una sorta di misura cautelare.
“È una situazione effettivamente anomala – spiega Anastasìa – rispetto alla quale c’è una difficoltà degli stessi operatori delle Rems ad avviare un piano terapeutico significativo, perché si tratta di persone che l’indomani potrebbero essere pienamente giudicate responsabili del fatto, tornare nell’istituto penitenziario, oppure addirittura essere prosciolte, assolte ed essere liberate, quindi questa è una difficoltà vera, che incide notevolmente sulla lista d’attesa, e su questo versante è importante una sensibilizzazione da parte della magistratura, quella che istruisce i procedimenti e decide sull’incapacità di intendere e di volere per evitare che troppo facilmente ci sia un’associazione tra malattia mentale e pericolosità sociale. Di fronte al presunto autore di reato che abbia problemi di salute mentale più o meno evidenti, la reazione in qualche modo immediata da parte degli organi giudiziari è quella di predisporre una misura cautelare, in questo modo le Rems si saturano facilmente”.
Ma è una mancanza di sensibilità governativa o degli organi giudiziari?
Secondo me è una preoccupazione da parte della magistratura che quando c’è un reato commesso da un presunto malato mentale ha come naturale propensione di mettere in qualche modo in sicurezza e sotto custodia queste persone e si ricorre con eccessiva facilità all’internamento nelle Rems, quindi è un problema culturale della magistratura; ma anche la società ha questi timori.
Ci sono poche Rems? Come si risolve il problema delle liste d’attesa?
Per un versante riducendo le persone indirizzate alle Rems, che sono immaginate dal legislatore come un’estrema ratio, quindi non tutti i malati di mente e gli autori di reato devono andarci. Bisogna avere una particolare pericolosità sociale, tale per cui non possono essere seguiti attraverso altre forme di cure e terapia o magari altre strutture. Qui si apre un altro versante: accanto alle Rems i dipartimenti di salute mentale devono in qualche modo sostenere una capacità di accoglienza da parte di residenze e strutture terapeutiche sul territorio che non necessariamente devono avere le caratteristiche delle Rems, cioè non necessariamente devono essere delle strutture chiuse. E’ chiaro che in assenza di questa capacità di presa in carico sul territorio tutto finisce sulle Rems e le Rems non reggono.
Perché al Nord non ci sono liste d’attesa?
Questo dipende da una diversa capacità di organizzazione dei servizi sul territorio. Non è che al Nord ci sia una maggiore capienza nelle Rems. La regione Lazio ha 91 posti in Rems sui 600 che ci sono in Italia, parliamo di una regione che non avendo 1/6 della popolazione italiana ha quasi 1/6 dei posti in Rems. Laddove ci sono servizi di salute mentale sul territorio che possono prendere in carico persone che abbiano commesso reati minori, seguirli e se necessario ospitarli in strutture terapeutiche territoriali, le Rems non si affollano. Viceversa, laddove il territorio non offre queste possibilità tutto viene rivolto alle strutture contenitive delle Rems. Si rischia di cadere dalla padella alla brace, in fondo gli ospedali giudiziari che sono stati chiusi erano questo. Se si vuole dare seguito a quella riforma bisogna essere capaci di costruire una capacità di presa in carico del territorio nel suo complesso, che riduca i tempi di permanenza per esempio in Rems. Quando gli operatori della Rems ritengono che il paziente sia maturo per lasciare la struttura in assenza di una struttura familiare solida, di una ospitalità, non si sa dove mandarle queste persone. Dopo 6 mesi-un anno si può rivalutare la pericolosità sociale e riconoscere che la persona può stare in una struttura residenziale terapeutica sul territorio, ma per far questo è necessario che il territorio sia attrezzato, accogliente.
Quanti incontri sono previsti, a quando il prossimo tavolo?
Non abbiamo uno scadenziario preciso, ma realisticamente quattro volte l’anno.
Tra i partecipanti al tavolo tecnico anche una rappresentanza dei pazienti. Si rendono conto dell’importanza data loro in questa circostanza?
Mi è sembrato che fossero ben consapevoli dell’importanza di questa partecipazione, che hanno utilizzato per rappresentare i problemi che hanno dentro. Ci hanno costretto ad ascoltare le loro problematiche di ordine pratico e organizzativo, della possibilità di svolgere attività di studio e di formazione al lavoro. Dopo aver superato i momenti di scompenso ritengono di dover superare anche queste sfide.
La riforma della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e la nascita delle Rems non si può esaurire in questo semplice cambiamento, da quei grandi istituti a queste piccole strutture. Ma comporta una diversa modalità di funzionamento di tutti i servizi di salute mentale. Il lavoro è molto lungo e va esteso a tutti i servizi di salute mentale, sul territorio, dentro gli istituti di pena, dentro le Rems. La riforma è a tutto campo, questa è la sfida che abbiamo davanti, con tutta la fatica del caso.
Per adesso il passo del “tavolo del dialogo” delle parti in causa, voluto dal Commissario straordinario della Asl Roma 5, Giuseppe Quintavalle, ha dato stimoli a una nuova forma di collaborazione che certamente porterà maggior chiarezza, obbligando ciascuno degli attori in campo a fare il suo lavoro, al meglio.
@vanessaseffer

 Dal 2015, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) hanno sostituito i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). Queste strutture sanitarie accolgono di fatto autori di reati molto gravi essendo affetti da disturbi mentali ed essendo conseguentemente socialmente pericolosi. La gestione interna delle Rems è di esclusiva competenza sanitaria, quindi delle Asl. Qui le persone vengono curate, non recluse, quindi si tratta di “pazienti”. Il tempo massimo di permanenza nella Rems non può essere superiore al massimo della pena prevista del reato del paziente. Qui, pertanto, dovrebbero intervenire in modo essenzialmente perfetto le parti in causa: i medici, la magistratura, la politica.
Dal 2015, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) hanno sostituito i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). Queste strutture sanitarie accolgono di fatto autori di reati molto gravi essendo affetti da disturbi mentali ed essendo conseguentemente socialmente pericolosi. La gestione interna delle Rems è di esclusiva competenza sanitaria, quindi delle Asl. Qui le persone vengono curate, non recluse, quindi si tratta di “pazienti”. Il tempo massimo di permanenza nella Rems non può essere superiore al massimo della pena prevista del reato del paziente. Qui, pertanto, dovrebbero intervenire in modo essenzialmente perfetto le parti in causa: i medici, la magistratura, la politica.
 La XVIII legislatura ha tagliato il nastro e non vediamo l’ora di vedere come cambierà il vento almeno per quanto riguarda la situazione della sanità. I disservizi del Sistema sanitario nazionale (Ssn) non sono mai diminuiti, anzi, al contrario, sono aumentati. Il Paese è sempre più spaccato, con un Nord dove gli ospedali sembrano funzionare meglio e un Sud dove perlopiù arrancano e in cui le liste d’attesa sono lunghissime e da accettare con rassegnazione, dove se ti dice bene per fare una tac possono passare tre anni.
La XVIII legislatura ha tagliato il nastro e non vediamo l’ora di vedere come cambierà il vento almeno per quanto riguarda la situazione della sanità. I disservizi del Sistema sanitario nazionale (Ssn) non sono mai diminuiti, anzi, al contrario, sono aumentati. Il Paese è sempre più spaccato, con un Nord dove gli ospedali sembrano funzionare meglio e un Sud dove perlopiù arrancano e in cui le liste d’attesa sono lunghissime e da accettare con rassegnazione, dove se ti dice bene per fare una tac possono passare tre anni. La prevenzione delle malattie infettive è il primo obiettivo della Sanità pubblica. Il 10 marzo è scaduto il termine fissato dalla legge per la presentazione della documentazione per l’adempimento degli obblighi vaccinali per le famiglie.
La prevenzione delle malattie infettive è il primo obiettivo della Sanità pubblica. Il 10 marzo è scaduto il termine fissato dalla legge per la presentazione della documentazione per l’adempimento degli obblighi vaccinali per le famiglie.
 La situazione delle carceri italiane è sempre più drammatica, il tasso di sovraffollamento del 113,2 per cento (secondo il rapporto di Antigone sulle carceri presentato alla Camera dei deputati il 27 luglio del 2017) di cui solo sporadicamente si parla, è argomento che finisce poi per un certo tempo nel dimenticatoio perché non è pregnante durante le campagne elettorali. Ma è un altro l’aspetto su cui ci vogliamo concentrare: i suicidi nelle carceri, poiché i numeri sono preoccupanti ed è un argomento di cui è doveroso doversi occupare. Dal 2008 si contano 500 suicidi, nonostante il Piano nazionale per prevenirli. Da allora il Sistema sanitario nazionale (Ssn) è impegnato nel ricercare formule per ridimenzionare questi fenomeni di disperazione insieme all’amministrazione penitenziaria, che è comunque titolare del funzionamento delle carceri e della gestione dei detenuti. A farne le spese sono anche le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, perché trascorrere molte ore dentro a un carcere per lavorare non è facile.
La situazione delle carceri italiane è sempre più drammatica, il tasso di sovraffollamento del 113,2 per cento (secondo il rapporto di Antigone sulle carceri presentato alla Camera dei deputati il 27 luglio del 2017) di cui solo sporadicamente si parla, è argomento che finisce poi per un certo tempo nel dimenticatoio perché non è pregnante durante le campagne elettorali. Ma è un altro l’aspetto su cui ci vogliamo concentrare: i suicidi nelle carceri, poiché i numeri sono preoccupanti ed è un argomento di cui è doveroso doversi occupare. Dal 2008 si contano 500 suicidi, nonostante il Piano nazionale per prevenirli. Da allora il Sistema sanitario nazionale (Ssn) è impegnato nel ricercare formule per ridimenzionare questi fenomeni di disperazione insieme all’amministrazione penitenziaria, che è comunque titolare del funzionamento delle carceri e della gestione dei detenuti. A farne le spese sono anche le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, perché trascorrere molte ore dentro a un carcere per lavorare non è facile. Sono in corso da vent’anni studi osservazionali che mirano a trovare un’associazione fra l’uso di aspirina a lungo termine e un ridotto rischio di sviluppare alcuni tumori, come il cancro colon-rettale. Ogni anno in Italia 34mila persone si ammalano di carcinoma al colon retto e circa 17mila ne muoiono. L’ipotesi di ricerca su cui gli scienziati stanno lavorando, è che le piastrine siano coinvolte nelle fasi iniziali della cancerogenesi colon-rettale e che l’azione protettiva dell’aspirina possa inibire l’attivazione piastrinica. È interessante vedere come l’acido acetilsalicilico, comunemente chiamato aspirina, nato circa 120 anni fa, utilizzato come antipiretico per ridurre la febbre, come analgesico per dolori lievi e come antinfiammatorio, possa rappresentare un importante strumento d’indagine per comprendere alcuni aspetti della formazione di un tumore ed essere fondamentale nella prevenzione della sua ricorrenza. L’aspirina è oggi classificata come farmaco antiaggregante per il suo effetto fluidificante sul sangue. Ciò per merito del farmacologo professor Carlo Patrono, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che scoprì circa trent’anni fa che l’aspirina a basse dosi (75-100 mg) riduce la sintesi del trombossano, che è un potente aggregante delle piastrine, le quali sono fondamentali per l’occlusione e la formazione del trombo alle coronarie (infarto) o cerebrali (ictus). Dunque è proprio dal papà dell’“aspirinetta” che ci facciamo spiegare dove è arrivata oggi la scienza e se c’è una relazione fra l’esposizione all’aspirina e la ridotta incidenza di un certo tumore.
Sono in corso da vent’anni studi osservazionali che mirano a trovare un’associazione fra l’uso di aspirina a lungo termine e un ridotto rischio di sviluppare alcuni tumori, come il cancro colon-rettale. Ogni anno in Italia 34mila persone si ammalano di carcinoma al colon retto e circa 17mila ne muoiono. L’ipotesi di ricerca su cui gli scienziati stanno lavorando, è che le piastrine siano coinvolte nelle fasi iniziali della cancerogenesi colon-rettale e che l’azione protettiva dell’aspirina possa inibire l’attivazione piastrinica. È interessante vedere come l’acido acetilsalicilico, comunemente chiamato aspirina, nato circa 120 anni fa, utilizzato come antipiretico per ridurre la febbre, come analgesico per dolori lievi e come antinfiammatorio, possa rappresentare un importante strumento d’indagine per comprendere alcuni aspetti della formazione di un tumore ed essere fondamentale nella prevenzione della sua ricorrenza. L’aspirina è oggi classificata come farmaco antiaggregante per il suo effetto fluidificante sul sangue. Ciò per merito del farmacologo professor Carlo Patrono, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che scoprì circa trent’anni fa che l’aspirina a basse dosi (75-100 mg) riduce la sintesi del trombossano, che è un potente aggregante delle piastrine, le quali sono fondamentali per l’occlusione e la formazione del trombo alle coronarie (infarto) o cerebrali (ictus). Dunque è proprio dal papà dell’“aspirinetta” che ci facciamo spiegare dove è arrivata oggi la scienza e se c’è una relazione fra l’esposizione all’aspirina e la ridotta incidenza di un certo tumore.


