 Una bomba ad orologeria è ormai innescata nella sanità pubblica del Paese e il tempo sta scorrendo velocemente senza quasi che i media, la politica e il grande pubblico ne abbiano consapevolezza. Solo tra gli addetti ai lavori sembra alzarsi alto il grido di allarme fatto proprio dal mondo delle organizzazioni sindacali di categoria nella loro interezza e, almeno in questo caso, senza divisioni al proprio interno. Il paventato pericolo di un progressivo impoverimento del personale medico operante nel sistema sanitario nazionale (Ssn) per il sopraggiungere di uno scalino pensionistico, è ormai una realtà concreta. Ragionando su dati Miur, Istat, Enpam e Fnomceo la realtà attuale per quanto riguarda le dinamiche pensionistiche evidenzia come circa 48mila medici nati nel decennio 1950-1960, ed oggi ancora attivi nel Ssn, hanno già maturato o matureranno i criteri previsti dalla legge “Fornero” nel decennio 2016-2025. Secondo i dati della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri i medici attivi in Italia al 2016, di età inferiore ai 70 anni, erano circa 354mila dei quali quasi 102mila unità attivi a vario titolo nelle aziende sanitarie locali.
Una bomba ad orologeria è ormai innescata nella sanità pubblica del Paese e il tempo sta scorrendo velocemente senza quasi che i media, la politica e il grande pubblico ne abbiano consapevolezza. Solo tra gli addetti ai lavori sembra alzarsi alto il grido di allarme fatto proprio dal mondo delle organizzazioni sindacali di categoria nella loro interezza e, almeno in questo caso, senza divisioni al proprio interno. Il paventato pericolo di un progressivo impoverimento del personale medico operante nel sistema sanitario nazionale (Ssn) per il sopraggiungere di uno scalino pensionistico, è ormai una realtà concreta. Ragionando su dati Miur, Istat, Enpam e Fnomceo la realtà attuale per quanto riguarda le dinamiche pensionistiche evidenzia come circa 48mila medici nati nel decennio 1950-1960, ed oggi ancora attivi nel Ssn, hanno già maturato o matureranno i criteri previsti dalla legge “Fornero” nel decennio 2016-2025. Secondo i dati della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri i medici attivi in Italia al 2016, di età inferiore ai 70 anni, erano circa 354mila dei quali quasi 102mila unità attivi a vario titolo nelle aziende sanitarie locali.
Si tratta di una fascia di età per le quali il riscatto previdenziale degli anni di studi universitari era facilitato da un versamento economico mensile sostenibile; inoltre, l’assunzione avveniva precocemente dopo il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia, dato che non vi era l’obbligo, come invece avviene attualmente, di possedere il titolo di specializzazione per essere assunti nel Ssn. A questa situazione consegue direttamente il rischio di un decadimento nella qualità dei servizi erogati proprio a causa della perdita di medici esperti e in possesso di elevate capacità professionali e di quella esperienza “sul campo” che è fondamentale per la tutela della salute di ognuno di noi. Nel decennio 2016-2025 i cessati attesi complessivi sono stimabili in oltre 55mila unità, un numero di poco inferiore rispetto a quello complessivo di nuovi specialisti che completeranno l’iter formativo specialistico nelle università nel decennio considerato, previsti in oltre 57mila, secondo un dato desumibile dalla media annuale dei contratti Miur degli ultimi tre anni: 5.711 contratti di formazione specialistica. Il dato però merita la massima attenzione perché, basandosi esclusivamente sul numero complessivo, questo risulta essere fuorviante poiché l’apparente equilibrio tra futuri cessati complessivi (medici ospedalieri-universitari-specialisti ambulatoriali) e futuri neo-specialisti, non potrà essere risolutivo a motivo dell’esistenza del doppio imbuto, formativo e lavorativo.
Nei prossimi dieci anni i numeri previsti di contratti specialistici Miur, considerando la media degli ultimi tre anni, garantiranno un equilibrio per le categorie degli universitari e degli specialisti ambulatoriali, non per gli specialisti dipendenti del Ssn, sia ospedalieri che territoriali. Questo si spiega perché la componente ospedaliera e dei servizi dipendente del Ssn che andrà in quiescenza sarà preponderante sulla componente degli universitari e specialisti ambulatoriali (oltre 47mila cessati Ssn versus gli oltre 8mila cessati per le altre due categorie intese in maniera accorpata per facilità di calcolo). Inoltre, se consideriamo quali tipologie di specialisti andranno in pensione, ci accorgiamo che per alcuni di essi, in maniera particolare internisti, pediatri, chirurghi generali e ginecologi, per non parlare della carenza attualissima e drammatica di medici dell’emergenza e pronto soccorso che rappresentano nel Ssn la prima linea di fuoco, e tutto questo per motivi noti che però l’evidenza insegna si è ancora restii ad affrontare (altri costi assicurativi, stipendi non adeguati alla complessità del lavoro ed ai rischi connessi, aumentato contenzioso medico legale, aumentata conflittualità con i pazienti a volte sfocianti in veri e propri atti di violenza nei confronti degli operatori).
È questo uno scenario estremamente complesso nel quale insistono, un ormai decennale mancato turnover che ha determinato gravi vuoti nelle dotazioni organiche e il già evidenziato mancato ricambio generazionale. Tali carenze sono ulteriormente emerse con la necessità di essere ottemperanti alle direttive europee sull’orario di lavoro come previsto con la Legge numero 161 del 30 ottobre 2014. A tutto ciò si aggiunge il mancato rinnovo del contratto ai medici e ai dirigenti, che accentuerà la fuga dei camici bianchi. Ci si lamenta che non ci saranno medici in futuro, eppure non ci sono stati sufficienti accantonamenti per dare dignità alla professione dei medici. La Cisl medici si batte da tempo per far comprendere che la sanità non è un costo ma un fattore produttivo. Dalla politica, dal ministro della Salute e dalle regioni sembra esserci disinteresse totale su questo tema. D’altra parte, i nostri medici non sono certo stimolati a rimanere in servizio, considerando che tra i fattori che invitano ad uscire dal Ssn vi è anche la bassa probabilità di raggiungere posizioni apicali, i cosiddetti primari, anche a motivo della costante diminuzione dei posti disponibili di direttore di struttura complessa a motivo degli accorpamenti o dell’abolizione di tali strutture per motivi economici o semplicemente politici.
Inoltre, l’età media dei nostri medici è di circa 55 anni e ad oggi non si è dato seguito ad una indicazione contrattuale a seguito della quale ai professionisti con più di 55 anni di età si sarebbero dovuti evitare i turni di guardia notturna. Cosa questa peraltro impossibile considerato che negli ospedali e nelle Asl la difficoltà di godere delle ferie e perfino dei turni di riposo è evidenza derivante anche dall’aumento della conflittualità tra professionisti ed aziende. È del tutto palese che un medico cui è stata tolta una valida aspettativa di carriera, privato di gratificazioni professionali anche di tipo economico, costretto dalla carenza di organici e dalla necessità nei servizi ospedalieri di garantire una assistenza nelle 24 ore con stressanti turni di guardia ed una gravosa mole di lavoro straordinario, in presenza di condizioni di elevato rischio professionale, appena ne ha la possibilità previdenziale si ritira in pensione ed inizia o continua a svolgere attività di tipo esclusivamente privata.
La gravità della situazione è tale che ogni anno aumenta il numero di medici che fanno domanda per lavorare all’estero e poi finiscono realmente per andare a lavorare in altri Paesi europei, negli Stati Uniti, e, molto recentemente, nei Paesi arabi attirati da stipendi assai elevati. Secondo i dati Istat, i professionisti del settore sanitario che hanno chiesto al ministero della Salute la documentazione utile per esercitare all’estero sono passati da 396 nel 2009 a 2.363 nel 2014 (+ 596 per cento). Il dato è talmente clamoroso che non può non fare riflettere. Ormai circa mille laureati o specialisti emigrano ogni anno. Peraltro, bisogna tenere conto che per formare ogni medico il Paese investe circa 150mila euro l’anno. In termini economici, è come se regalassimo un migliaio di “rosse di Maranello” all’anno agli altri Paesi europei ed extra europei. Chiaramente il danno che ne risulta è solo apparentemente di tipo esclusivamente economico perché ci impoveriamo in senso letterale di cervelli e di saperi professionali, sottratti allo sviluppo scientifico e culturale del nostro Paese, salvo poi, a sequenza regolare, pontificare sulla necessità di fare rientrare i cervelli nel nostro Paese. La soluzione è evidente: cerchiamo di non farli partire.
@vanessaseffer

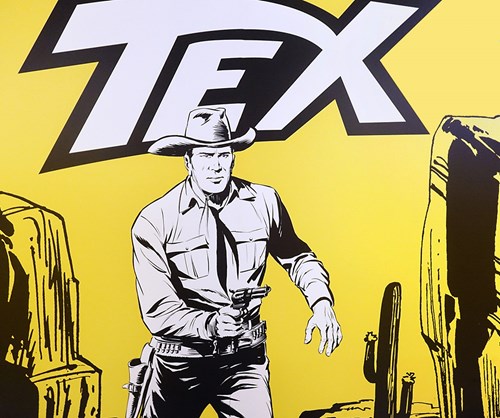

 Una struttura sanitaria accreditata è una struttura privata che ha stipulato una convenzione con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), dunque eroga le prestazioni sanitarie chiedendo al cittadino il solo pagamento del ticket. Ma come fa una struttura privata ad accreditarsi? È l’autorità sanitaria delle singole regioni ad individuare le strutture che secondo loro sono in grado di garantire il livelli essenziali di assistenza, di valutare l’idoneità delle stesse, di assicurarsi che siano qualificate e di accertarsi dell’efficacia e dell’appropriatezza dei risultati, fissando il volume massimo delle prestazioni da rendere nell’ambito della competenza territoriale della medesima azienda sanitaria locale.
Una struttura sanitaria accreditata è una struttura privata che ha stipulato una convenzione con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), dunque eroga le prestazioni sanitarie chiedendo al cittadino il solo pagamento del ticket. Ma come fa una struttura privata ad accreditarsi? È l’autorità sanitaria delle singole regioni ad individuare le strutture che secondo loro sono in grado di garantire il livelli essenziali di assistenza, di valutare l’idoneità delle stesse, di assicurarsi che siano qualificate e di accertarsi dell’efficacia e dell’appropriatezza dei risultati, fissando il volume massimo delle prestazioni da rendere nell’ambito della competenza territoriale della medesima azienda sanitaria locale.
 Ieri a Crotone al termine del suo turno all’ospedale civile San Giovanni di Dio, un medico, che presta servizio presso l’unità complessa del nosocomio calabrese, appena uscita dalla struttura è stata aggredita da un cinquantenne crotonese che l’attendeva con il volto e la testa coperti da un cappuccio e da una sciarpa, colpendola al collo con un cacciavite. A salvarla da un altro fendente è stato un ambulante marocchino che sosta quotidianamente con la sua bancarella per vendere oggetti per automobili proprio davanti all’ospedale. Cercando di aiutare la dottoressa, lo straniero ha chiamato prima i sanitari che sono accorsi e l’hanno ricoverata in codice rosso e subito operata, e poi ha inseguito il malfattore bloccandolo su un bidone della spazzatura fino all’arrivo della polizia. La dottoressa, fortunatamente, non è in pericolo di vita.
Ieri a Crotone al termine del suo turno all’ospedale civile San Giovanni di Dio, un medico, che presta servizio presso l’unità complessa del nosocomio calabrese, appena uscita dalla struttura è stata aggredita da un cinquantenne crotonese che l’attendeva con il volto e la testa coperti da un cappuccio e da una sciarpa, colpendola al collo con un cacciavite. A salvarla da un altro fendente è stato un ambulante marocchino che sosta quotidianamente con la sua bancarella per vendere oggetti per automobili proprio davanti all’ospedale. Cercando di aiutare la dottoressa, lo straniero ha chiamato prima i sanitari che sono accorsi e l’hanno ricoverata in codice rosso e subito operata, e poi ha inseguito il malfattore bloccandolo su un bidone della spazzatura fino all’arrivo della polizia. La dottoressa, fortunatamente, non è in pericolo di vita.
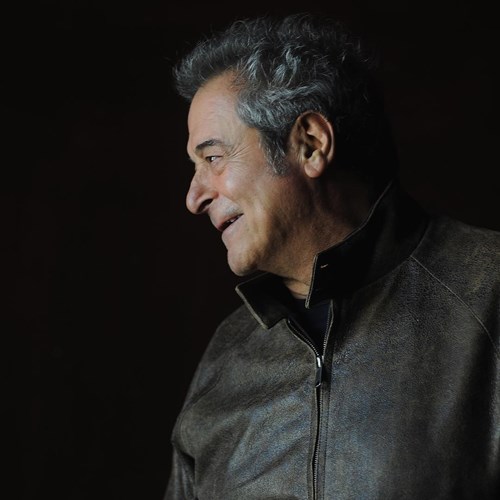
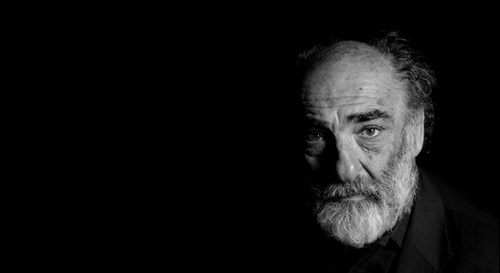
 Gli operatori dei servizi sanitari presentano un rischio significativo di subire atti di violenza durante la propria attività lavorativa. Si tratta di un fenomeno così rilevante che il ministero della Salute ha emanato una specifica raccomandazione sull’argomento e ha inserito la “morte o grave danno in seguito a violenza su operatore” fra gli eventi sentinella che devono essere segnalati attraverso il flusso Simes. La Regione Lazio nello scorso luglio ha istituito l’Osservatorio regionale per la sicurezza degli operatori Sanitari e ha recentemente approvato un “Documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” elaborato dal Centro regionale rischio clinico. Per queste ragioni abbiamo voluto sentire Giuseppe Sabatelli, coordinatore del Centro e risk manager della Asl Roma 5.
Gli operatori dei servizi sanitari presentano un rischio significativo di subire atti di violenza durante la propria attività lavorativa. Si tratta di un fenomeno così rilevante che il ministero della Salute ha emanato una specifica raccomandazione sull’argomento e ha inserito la “morte o grave danno in seguito a violenza su operatore” fra gli eventi sentinella che devono essere segnalati attraverso il flusso Simes. La Regione Lazio nello scorso luglio ha istituito l’Osservatorio regionale per la sicurezza degli operatori Sanitari e ha recentemente approvato un “Documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” elaborato dal Centro regionale rischio clinico. Per queste ragioni abbiamo voluto sentire Giuseppe Sabatelli, coordinatore del Centro e risk manager della Asl Roma 5.
 L’attitudine dell’uomo è quella di ammalarsi. Presto o tardi, ciascuno di noi ha a che fare con un medico, un Pronto soccorso o una guardia medica. Una delle poche certezze che ha il cittadino italiano è quella di trovare nel nostro Paese un Pronto soccorso aperto 24 ore su 24. Qui vengono prestate le prime cure a tutti i casi di urgenza ed emergenza gratuitamente con spazi dedicati alla breve osservazione. I numerosi casi di violenza contro i medici e gli operatori sanitari segnalati in questi ultimi mesi hanno dato vita a un nuovo fenomeno sociale. Molti medici, infatti, temono le reazioni dei pazienti. Un problema che va affrontato da varie sfaccettature. Pertanto questo argomento merita un adeguato approfondimento con Federico Spandonaro, professore di Economia e Management sanitario presso l’Università di Tor Vergata e presidente di “Crea Sanità”, il Consorzio per la Ricerca economica applicata in sanità, per avere un punto di vista tecnico e per spiegarci come migliorare l’immagine della sanità italiana, essendo una delle migliori al mondo, agli occhi del cittadino italiano.
L’attitudine dell’uomo è quella di ammalarsi. Presto o tardi, ciascuno di noi ha a che fare con un medico, un Pronto soccorso o una guardia medica. Una delle poche certezze che ha il cittadino italiano è quella di trovare nel nostro Paese un Pronto soccorso aperto 24 ore su 24. Qui vengono prestate le prime cure a tutti i casi di urgenza ed emergenza gratuitamente con spazi dedicati alla breve osservazione. I numerosi casi di violenza contro i medici e gli operatori sanitari segnalati in questi ultimi mesi hanno dato vita a un nuovo fenomeno sociale. Molti medici, infatti, temono le reazioni dei pazienti. Un problema che va affrontato da varie sfaccettature. Pertanto questo argomento merita un adeguato approfondimento con Federico Spandonaro, professore di Economia e Management sanitario presso l’Università di Tor Vergata e presidente di “Crea Sanità”, il Consorzio per la Ricerca economica applicata in sanità, per avere un punto di vista tecnico e per spiegarci come migliorare l’immagine della sanità italiana, essendo una delle migliori al mondo, agli occhi del cittadino italiano.
 È il medico più citato d’Italia perché la sua legge 8 marzo 2017 n. 24 ha cambiato le “Disposizioni in materia delle cure e della persona assistita nonché in materia della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, così recita nell’incipit. Federico Gelli con la sua norma ha ridefinito il rapporto medico-paziente, permettendo ai professionisti di svolgere il loro lavoro con maggior serenità e garantendo ai pazienti maggior trasparenza ed eventuali risarcimenti in tempi brevi.
È il medico più citato d’Italia perché la sua legge 8 marzo 2017 n. 24 ha cambiato le “Disposizioni in materia delle cure e della persona assistita nonché in materia della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, così recita nell’incipit. Federico Gelli con la sua norma ha ridefinito il rapporto medico-paziente, permettendo ai professionisti di svolgere il loro lavoro con maggior serenità e garantendo ai pazienti maggior trasparenza ed eventuali risarcimenti in tempi brevi.
 Non si fermano i casi di aggressione negli ospedali. L’ultimo episodio lo scorso fine settimana a Civitavecchia: a farne le spese è stato un infermiere aggredito da un paziente in crisi di astinenza da alcool.
Non si fermano i casi di aggressione negli ospedali. L’ultimo episodio lo scorso fine settimana a Civitavecchia: a farne le spese è stato un infermiere aggredito da un paziente in crisi di astinenza da alcool.
 Perché rischiare la vita per curare? “Ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica sul posto di lavoro è considerato un problema di salute pubblica nel mondo” secondo il National Institute of Occupational Safety and Health. Una cosa che accomuna tutti i Paesi del mondo su questo tema è il fatto che spesso la maggior parte degli avvenimenti di violenza (l’85 per cento delle volte) non viene denunciata da chi li subisce, più che altro per paura, a meno che non vi siano lesioni a documentare i fatti. C’è poi l’annosa questione sulla definizione di cosa o come definire una violenza o “quando” la si possa definire tale, vivendo spesso in una situazione ambientale che propende a sminuire, tesa ad assolvere o, peggio, incapace di riconoscere certi abusi. L’invito è a non minimizzare. Il primo capitale delle Istituzioni è il capitale umano.
Perché rischiare la vita per curare? “Ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica sul posto di lavoro è considerato un problema di salute pubblica nel mondo” secondo il National Institute of Occupational Safety and Health. Una cosa che accomuna tutti i Paesi del mondo su questo tema è il fatto che spesso la maggior parte degli avvenimenti di violenza (l’85 per cento delle volte) non viene denunciata da chi li subisce, più che altro per paura, a meno che non vi siano lesioni a documentare i fatti. C’è poi l’annosa questione sulla definizione di cosa o come definire una violenza o “quando” la si possa definire tale, vivendo spesso in una situazione ambientale che propende a sminuire, tesa ad assolvere o, peggio, incapace di riconoscere certi abusi. L’invito è a non minimizzare. Il primo capitale delle Istituzioni è il capitale umano.
