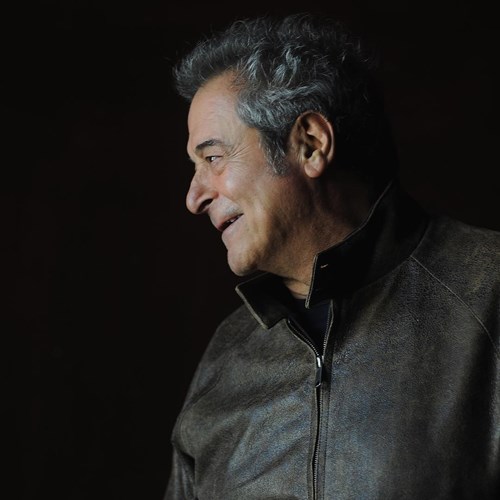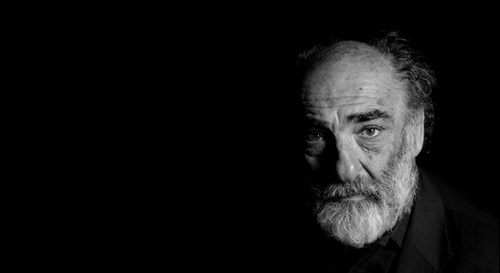Si dice spesso, ed a ragione, che alcuni servizi erogati per le intere 24 ore dalla sanità pubblica, ed è questo il caso del pronto soccorso, della chirurgia in urgenza, dei reparti di degenza solo per citare alcuni esempi, siano ormai tra i pochi che effettivamente danno risposte immediate e concrete al bisogno assistenziale espresso dai cittadini. Eppure la percezione è che molti cittadini non abbiano la consapevolezza di questa realtà che continua ad essere operativa pur tra le mille difficoltà derivanti dalle ormai croniche carenze di personale ed i molti deficit organizzativi e strutturali che caratterizzano le aziende sanitarie. È una dinamica complessa anche da un punto psicologico. Entrando in casa si spinge l’interruttore ed ecco che si accende la lampadina. Se poi si rimane al buio ci si dirige verso il quadro elettrico e si cerca di capire se è scattata la leva chiamata, non a caso, salvavita. La si solleva e finalmente ecco la luce e la tranquillità che ne deriva. Pensiamo a cosa potrebbe accadere se sollevando la leva non ottenessimo il ritorno della luce: preoccupazione, disagio, forse panico perchè non se ne capisce il motivo.
Pensiamo ora a quale reazione potremmo avere di fronte ad una interruzione delle prestazioni sanitarie. Certo si dirà che i medici andrebbero incontro a problematiche giudiziarie e disciplinari perchè l’interruzione di pubblico servizio, oltre ad essere di per sè esecrabile, costituisce un reato e come tale è condannabile. Pensiamo peró a cosa accadrebbe se i medici si attenessero rigidamente a ció che detta il contratto, peraltro in ritardo di dieci anni, se evitassero di fare ore di straordinario, peraltro spesso non pagate e compensabili con ipotetici successivi riposi pressochè impossibili da usufruire considerata la diffusa povertá degli organici di personale. Cosa accadrebbe se i medici, stretti tra le pastoie burocratiche, le accuse di malpractice, gli spot pubblicitari che li dipingono quasi alla stregua di criminali, si limitassero a fare nulla di più di ció che è il loro mandato professionale di diagnosi e cura? Qualcuno direbbe che sarebbe già tanto e che si accontenterebbe di questo perchè ognuno di noi ha una esperienza negativa da raccontare, un ricordo della memoria. Ma torniamo alla frontiera del Pronto Soccorso che dovrebbe rappresentare l’interfaccia tra ospedale e territorio, il servizio dove in prima istanza si rivolgono i cittadini con problemi di salute reputati urgenti.
Nella specifica pagina del Ministero della SaIute si legge che “i servizi di pronto soccorso e di accettazione svolgono attività di accettazione per i casi elettivi e programmati e per quelli che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere di emergenza-urgenza, nonché per i soggetti in condizioni di urgenza differibile, indifferibile e in condizioni di emergenza”.
Dalla lettura della definizione di Pronto Soccorso si trae la conclusione che esso rappresenta il principale biglietto da visita dell’ospedale. Tuttavia le immagini di affollamento e sovraffollamento dei PS, accentuate dai picchi influenzali del periodo, non fanno pensare a quei criteri di affidabilità ed efficienza che dovrebbero caratterizzare una sanità che funziona e dunque nell’immaginario collettivo ne risulta alterata la percezione del buon funzionamento della stessa. Le attese per essere visitati e per essere ricoverati, nei Pronto Soccorso della penisola, sono la evidente dimostrazione di come i tagli lineari cui è stato sottoposto il Sistema Sanitario Nazionale negli ultimi anni abbiano avuto delle pesanti conseguenze sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini. Cittadini che peró non si pongono il quesito sulle responsabilità politiche di questo dissesto e, limitandosi a spingere l’interruttore della luce e non ottenendo con immediatezza l’accensione della lampadina, ovvero l’erogazione del servizio atteso, finiscono spesso ad alimentare le cronache quotidiane con atti sempre più frequenti di aggressione ai danni dei medici e degli altri operatori sanitari.
Secondo il Programma Nazionale Esiti (PNE) che è uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo, diffuso da Agenas, negli ultimi anni gli accessi di durata inferiore a 12 ore sono stati mediamenre intorno ai 15 milioni. Globalmente i dati 2017 parlano di circa 23.500.000 di accessi all’anno per le varie tipologie di codice e durata degli stessi. Si tratta di numeri enormi a fronte dei quali sono estremamente rari casi accertati di malasanità. I giorni iniziali di ogni anno sono poi sicuramente tra i più complicati per il sistema. La sintomatologia influenzale, febbre alta, mal di gola, raffreddore e problemi gastrointestinali, portano le strutture vicine al collasso per la grande affluenza di pazienti.
Ed ecco allora il teatrino della politica.Da un lato le accuse da parte delle opposizioni di inefficienza e di errata programmazione, dall’altra la conseguente risposta di chi governa gli enti regionali con l’elenco delle misure messe in campo per fronteggiare l’emergenza e limitare le difficoltà derivanti dall’iperaffollamento: l’invito a tutte le strutture a dimettere i pazienti 7 giorni su 7, compresi sabato e domenica; l’accordo con le strutture private per la gestione dei trasferimenti in ricovero ordinario; l’apertura degli ambulatori medici di famiglia il sabato e la domenica, compresi i giorni festivi; l’apertura di presidi per i pediatri di libera scelta il sabato e la domenica e nei festivi, ultimo e positivo esempio nel Lazio a Colleferro nell’ambito della Asl Roma 5.
Tutto già visto come da copione. Peró in prima fila a “beccarsi le pallottole” restano gli operatori sanitari. E allora viene spontaneo riproporre la proposta della Cisl Medici di far si che le aziende si costituiscano parte civile in caso di aggressione ai propri dipendenti che costituiscono la principale ricchezza della nostra sanità pubblica.
@vanessaseffer
Da Sanità Online News


 Si legge su Wikipedia che Enrica Bonaccorti, all’anagrafe Enrica Maria Silvia Adele Bonaccorti (Savona, 18 novembre di un certo anno), è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, paroliera e attrice italiana. Dunque, nel suo corposo curriculum vitae, oltre alle numerose trasmissioni televisive che l’hanno resa celebre, la Bonaccorti sarebbe anche una “paroliera”. Cercando sulla Treccani, si può leggere quanto segue: “Parolière, chi scrive i versi o le parole per una canzone o per altra composizione di musica leggera; in particolare chi adatta le parole a musica già composta”. È una definizione che rende onore alla signora. Sorte ben diversa è riservata sulla stessa enciclopedia al termine parolaio: “Persona che parla molto, che ama fare discorsi verbosi, generalmente futili, privi di corrispondenza con la realtà, o destinati a non tradursi in pratica: non dar retta a quel parolaio! Come aggettivo, che abbonda di parole, per lo più inconcludenti! Come in politica, che si riduce a vane parole e dove si fanno molti discorsi ma si conclude poco!”.
Si legge su Wikipedia che Enrica Bonaccorti, all’anagrafe Enrica Maria Silvia Adele Bonaccorti (Savona, 18 novembre di un certo anno), è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, paroliera e attrice italiana. Dunque, nel suo corposo curriculum vitae, oltre alle numerose trasmissioni televisive che l’hanno resa celebre, la Bonaccorti sarebbe anche una “paroliera”. Cercando sulla Treccani, si può leggere quanto segue: “Parolière, chi scrive i versi o le parole per una canzone o per altra composizione di musica leggera; in particolare chi adatta le parole a musica già composta”. È una definizione che rende onore alla signora. Sorte ben diversa è riservata sulla stessa enciclopedia al termine parolaio: “Persona che parla molto, che ama fare discorsi verbosi, generalmente futili, privi di corrispondenza con la realtà, o destinati a non tradursi in pratica: non dar retta a quel parolaio! Come aggettivo, che abbonda di parole, per lo più inconcludenti! Come in politica, che si riduce a vane parole e dove si fanno molti discorsi ma si conclude poco!”.
 Una bomba ad orologeria è ormai innescata nella sanità pubblica del Paese e il tempo sta scorrendo velocemente senza quasi che i media, la politica e il grande pubblico ne abbiano consapevolezza. Solo tra gli addetti ai lavori sembra alzarsi alto il grido di allarme fatto proprio dal mondo delle organizzazioni sindacali di categoria nella loro interezza e, almeno in questo caso, senza divisioni al proprio interno. Il paventato pericolo di un progressivo impoverimento del personale medico operante nel sistema sanitario nazionale (Ssn) per il sopraggiungere di uno scalino pensionistico, è ormai una realtà concreta. Ragionando su dati Miur, Istat, Enpam e Fnomceo la realtà attuale per quanto riguarda le dinamiche pensionistiche evidenzia come circa 48mila medici nati nel decennio 1950-1960, ed oggi ancora attivi nel Ssn, hanno già maturato o matureranno i criteri previsti dalla legge “Fornero” nel decennio 2016-2025. Secondo i dati della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri i medici attivi in Italia al 2016, di età inferiore ai 70 anni, erano circa 354mila dei quali quasi 102mila unità attivi a vario titolo nelle aziende sanitarie locali.
Una bomba ad orologeria è ormai innescata nella sanità pubblica del Paese e il tempo sta scorrendo velocemente senza quasi che i media, la politica e il grande pubblico ne abbiano consapevolezza. Solo tra gli addetti ai lavori sembra alzarsi alto il grido di allarme fatto proprio dal mondo delle organizzazioni sindacali di categoria nella loro interezza e, almeno in questo caso, senza divisioni al proprio interno. Il paventato pericolo di un progressivo impoverimento del personale medico operante nel sistema sanitario nazionale (Ssn) per il sopraggiungere di uno scalino pensionistico, è ormai una realtà concreta. Ragionando su dati Miur, Istat, Enpam e Fnomceo la realtà attuale per quanto riguarda le dinamiche pensionistiche evidenzia come circa 48mila medici nati nel decennio 1950-1960, ed oggi ancora attivi nel Ssn, hanno già maturato o matureranno i criteri previsti dalla legge “Fornero” nel decennio 2016-2025. Secondo i dati della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri i medici attivi in Italia al 2016, di età inferiore ai 70 anni, erano circa 354mila dei quali quasi 102mila unità attivi a vario titolo nelle aziende sanitarie locali.
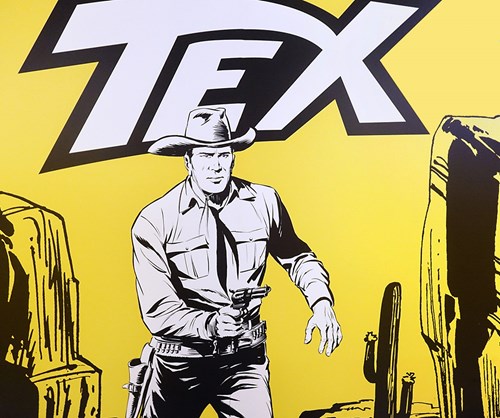

 Una struttura sanitaria accreditata è una struttura privata che ha stipulato una convenzione con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), dunque eroga le prestazioni sanitarie chiedendo al cittadino il solo pagamento del ticket. Ma come fa una struttura privata ad accreditarsi? È l’autorità sanitaria delle singole regioni ad individuare le strutture che secondo loro sono in grado di garantire il livelli essenziali di assistenza, di valutare l’idoneità delle stesse, di assicurarsi che siano qualificate e di accertarsi dell’efficacia e dell’appropriatezza dei risultati, fissando il volume massimo delle prestazioni da rendere nell’ambito della competenza territoriale della medesima azienda sanitaria locale.
Una struttura sanitaria accreditata è una struttura privata che ha stipulato una convenzione con il Sistema sanitario nazionale (Ssn), dunque eroga le prestazioni sanitarie chiedendo al cittadino il solo pagamento del ticket. Ma come fa una struttura privata ad accreditarsi? È l’autorità sanitaria delle singole regioni ad individuare le strutture che secondo loro sono in grado di garantire il livelli essenziali di assistenza, di valutare l’idoneità delle stesse, di assicurarsi che siano qualificate e di accertarsi dell’efficacia e dell’appropriatezza dei risultati, fissando il volume massimo delle prestazioni da rendere nell’ambito della competenza territoriale della medesima azienda sanitaria locale.
 Ieri a Crotone al termine del suo turno all’ospedale civile San Giovanni di Dio, un medico, che presta servizio presso l’unità complessa del nosocomio calabrese, appena uscita dalla struttura è stata aggredita da un cinquantenne crotonese che l’attendeva con il volto e la testa coperti da un cappuccio e da una sciarpa, colpendola al collo con un cacciavite. A salvarla da un altro fendente è stato un ambulante marocchino che sosta quotidianamente con la sua bancarella per vendere oggetti per automobili proprio davanti all’ospedale. Cercando di aiutare la dottoressa, lo straniero ha chiamato prima i sanitari che sono accorsi e l’hanno ricoverata in codice rosso e subito operata, e poi ha inseguito il malfattore bloccandolo su un bidone della spazzatura fino all’arrivo della polizia. La dottoressa, fortunatamente, non è in pericolo di vita.
Ieri a Crotone al termine del suo turno all’ospedale civile San Giovanni di Dio, un medico, che presta servizio presso l’unità complessa del nosocomio calabrese, appena uscita dalla struttura è stata aggredita da un cinquantenne crotonese che l’attendeva con il volto e la testa coperti da un cappuccio e da una sciarpa, colpendola al collo con un cacciavite. A salvarla da un altro fendente è stato un ambulante marocchino che sosta quotidianamente con la sua bancarella per vendere oggetti per automobili proprio davanti all’ospedale. Cercando di aiutare la dottoressa, lo straniero ha chiamato prima i sanitari che sono accorsi e l’hanno ricoverata in codice rosso e subito operata, e poi ha inseguito il malfattore bloccandolo su un bidone della spazzatura fino all’arrivo della polizia. La dottoressa, fortunatamente, non è in pericolo di vita.